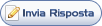Myshkin Myshkin 

Registrato: Settembre 2006
Messaggi: 4281
Residenza: Roma - Vologda

|
 «Luna Papa»
«Лунный Папа» «Luna Papa» di Bakhtiar Khudojnazarov 1999
A Farkhor, un piccolo villaggio dell’Asia Centrale, in Uzbekistan/Tagikistan, vicino all'antica città di Samarcanda, situato sulle sponde di un lago artificiale, si dipana l’esistenza dell’eccentrica famiglia Bekhmuradov: la compongono Mamlakat, una ragazza diciassettenne vitale, sognatrice e appassionata di teatro; suo fratello maggiore Nasreddin, che ha smarrito il senno dopo essere saltato su una mina in guerra e sta lentamente riacquistando la ragione; e il loro padre Safar, che alleva conigli ed è rimasto solo con i figli dopo la morte della moglie, sopravvenuta per complicazioni durante il parto di Mamlakat. Sbarcare il lunario è difficile per tutti: per le strade scorrazzano indisturbati ladri, truffatori e militari sbandati, oltre a bande di gangster che si fronteggiano in sanguinose sparatorie perfino in pieno giorno.Tuttavia Mamlakat, che recita e danza con un ensemble di ballerine dilettanti che si esibiscono vestite da… frutta e verdura (il gruppo “Il raccolto”), continua ostinatamente a coltivare le proprie aspirazioni artistiche: attende perciò con impazienza l’arrivo nel villaggio di una compagnia ambulante, scritturata per allestire nel locale teatro all’aperto alcuni classici drammi shakespeariani. Nel corso una notte di luna piena la ragazza, giunta in ritardo allo spettacolo e trovata l’arena ormai deserta, si avvia mestamente sulla strada di casa; lungo il tragitto però, al buio, viene sedotta da un misterioso individuo che si spaccia per attore (nonché per amico personale di Tom Cruise!), e quasi senza accorgersene fa l’amore con lui.
Ben presto Mamlakat si accorge di essere incinta, e si affretta a confidare all’amica Sube la sua decisione di abortire. Il ginecologo al quale si rivolge, però, perde accidentalmente la vita durante un regolamento di conti fra fuorilegge. Alla ragazza non rimane perciò che rivelare la gravidanza al padre, non prima di averlo immobilizzato con uno stratagemma per impedirgli di reagire troppo violentemente alla notizia. Infuriato, Safar prende con sé i figli a bordo del suo scassatissimo camioncino e inizia a perlustrare tutta la regione (in particolare le città più importanti, Samarcanda, Bukhara e Tashkent) alla ricerca del fedifrago: supponendo, in base ai racconti di Mamlakat, che possa trattarsi di un attore, Safar e Nasreddinsi… concentrano sulla categoria, irrompendo nel bel mezzo delle rappresentazioni e sequestrando una serie di probabili responsabili, senza peraltro ottenere alcun risultato. Nel corso di questi raid Mamlakat si imbatte in Alek, un giovane che si fa passare per un medico incaricato di effettuare prelievi sanguigni sulla popolazione (con la promessa di inesistenti compensi in dollari) ed è costretto a sfuggire rocambolescamente agli inseguimenti della polizia.
La spedizione dei Bekhmuradov si conclude con un nulla di fatto: padre e figli rientrano a mani vuote al villaggio, dove il sempre più vistoso stato interessante della ragazza (unito all’ormai palese assenza di un padre legittimo) solleva un’autentica ondata popolare di maldicenze e di emarginazione ai danni di Mamlakat; la quale, dopo aver nuovamente tentato – con l’aiuto di una fattucchiera, bloccata in extremis dagli uomini di famiglia – la via dell’aborto, si risolve disperata a fuggire in treno. Sullo stesso convoglio viaggia però anche Alek, stavolta nelle vesti di baro professionista ai danni dei viaggiatori di passaggio; smascherato, Mamlakat lo trae d’impaccio in un delicato frangente e lo segue persino quando viene gettato dal treno in corsa. Dopo tante vicissitudini i due si innamorano e decidono di fare ritorno in paese, accolti festosamente da Safar e Nasreddin; viene decisa la data per le nozze della nuova coppia, ma mentre la cerimonia è in pieno svolgimento Alek e Safar muoiono in seguito a un incidente assolutamente assurdo: schiacciati da un toro scagliato da un aereo in volo. Caso vuole che il pilota del medesimo aereo (in realtà un malfattore che con la sua banda ha messo a punto un ingegnoso sistema “volante” per sottrarre numerosi capi alle mandrie della regione) atterri al villaggio, finendo di lì a poco per ammettere alla sconsolata Mamlakat di essere lui stesso il vero padre del suo bambino e offrendosi di sposarla. La ragazza rifiuta rabbiosamente di unirsi all’assassino dei suoi cari; non solo,ma decisa a far giustizia gli spara anche addosso, e il violento shock che ne consegue fa piombare l’uomo in un profondo stato di catalessi. Il destino pare accanirsi sempre più con Mamlakat, tornata nel bersaglio delle angherie e dell’ostilità dei concittadini: ma proprio quando la situazione sembra precipitare, Nasreddin escogita un’imprevedibile soluzione che consente alla sorella di abbandonare per sempre il covo di intolleranza nel quale si trova a vivere, veleggiando nell’aria alla volta di altri (e più ospitali) orizzonti.
I Paesi che occupano la regione cosiddetta “transcaucasica” del continente asiatico (Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan) costituiscono, da tempo immemorabile, un vero e proprio crocevia di influssi culturali, linguistici, etnici e religiosi. In queste terre, il passaggio e lo stanziamento di popolazioni di ascendenza slava, turcomanna, araba, cinese, mongola, indiana ha dato origine a ogni genere di scambi, incroci, ibridazioni e stratificazioni, non senza provocare –
nel corso dei secoli – attriti e conflitti anche piuttosto aspri. Il crollo dell’Unione Sovietica ha restituito loro l’autonomia amministrativa e lo status di Repubblica, ma la distanza che le separa dai centri focali del mondo contemporaneo e la conseguente scarsa informazione su tutto ciò che vi avviene e che le riguarda – unito alle suggestioni leggendarie tuttora evocate dalle denominazioni stesse di alcune località, basti pensare a Samarcanda o a Bukhara – contribuisce a mantenerne i confini avvolti in un fitto alone di mistero.
Da alcuni anni, però, i principali festival internazionali hanno concesso largo spazio al cinema prodotto in quelle nazioni, mostrando finalmente ampi squarci del loro volto nascosto e non mancando di rivelare, al contempo, un certo numero di talenti di sicuro interesse.
Bakhtiar Khudojnazarov è forse, fra questi, il più noto e promettente: ripetutamente menzionato e premiato per i suoi primi due lavori, il giovane regista tagiko (nato a Dushanbé nel 1965) ha probabilmente firmato con Luna Papa l’opera della raggiunta maturità. Rapido, frenetico, colorato, generoso di situazioni divertenti e di momenti commoventi, il film esprime compiutamente l’aspirazione del suo autore a una sorta di “realismo fantastico” (la definizione è dello stesso Khudojnazarov) capace di rendere tangibili gli umori e lo spirito nei quali affonda le proprie radici: e l’impresa, stando agli esiti, può dirsi sicuramente riuscita. Debitore sia della grande tradizione della cinematografia asiatico-sovietica sia, per rintracciare un referente più recente, delle atmosfere ipercinetiche di un Emir Kusturica (non a caso anch’egli proveniente da un melting pot etnico-culturale analogo, quantunque giunto – come drammaticamente sappiamo – al punto di rottura dei fragili equilibri sui quali si fondava), Luna Papa si nutre del calibratissimo accordo che viene a stabilirsi fra il piano della scrittura e della narrazione e quello della resa linguistica ed espressiva: detto altrimenti, le tragicomiche vicende di Mamlakat e della “corte dei miracoli” che la circonda sono in grado di liberare tutte le risonanze morali di cui sono portatrici anche in virtù di un’originalità visiva, di una perizia nella direzione degli attori (tutti bravissimi) e di un apparato scenografico di notevole livello.A tal proposito, non sarà superfluo puntualizzare che l’ambientazione che fa da sfondo a Luna Papa, e cioè l’immaginaria cittadina di Farkhor, è stata costruita appositamente per il film su progetto dello scenografo Negmat Dzhuraev, straordinario per come ha saputo cogliere con grande efficacia l’ideale punto d’incontro fra verosimiglianza, concretezza “materiale” e atmosfere magico-surreali. Il filo rosso che annoda gli episodi vissuti da Mamlakat ripercorre quello, eterno e sempre uguale, della contrapposizione fra energia vitale e pulsioni di morte, fra la ricerca della felicità e tutto ciò che congiura per impedirne il pieno conseguimento: interdetti sociali, false giustificazioni morali, miopi e sterili dogmatismi che altro non producono se non invidia, odio, ostracismo, intolleranza. Gli uomini e le donne che affollano il villaggio non hanno volto, non hanno nome, sono semplicemente una massa indistinta di individui ostili e privi di calore umano. La malvagità e l’incomprensione sono prerogativa degli adulti, di chi ha definitivamente rinunciato a sognare; solo chi ha saputo conservare un animo “bambino”, chi ancora possiede il gusto del gioco, della danza, financo dello sberleffo all’ordine costituito (come Alek, truffatore dal cuore tenero e mancato padre putativo) può dirsi ancora veramente vivo: Mamlakat, certo, ma anche Nasreddin (la cui “pazzia” non gli impedisce – o forse addirittura gli consente – di distinguere chiaramente, al primo sguardo, fra Bene e Male) e in fondo lo stesso Safar, padre burbero ma protettivo e amorevole verso la bizzarra coppia di figli che, tra le altre sventure, gli è toccata in sorte. Si tratta, come si vede, di una storia raccontata mille e mille volte, ma che Khudojnazarov sa punteggiare di notazioni inedite e non banali, alternando sapientemente e con spiccato senso del ritmo (coadiuvato in questo dalle cadenze martellanti della partitura di Daler Nasarov) i registri dell’emozione e quelli – peraltro prevalenti – di un grottesco sapido e sfrenato: tutti urlano, gesticolano, si inseguono su e giù per il paese, litigano in continuazione coi pretesti più svariati. Un costante “sopra le righe” che tuttavia non appare mai forzato, ostentato, ma evidentemente trae la propria ragion d’essere da uno sguardo sincero e autentico su quella porzione di pianeta e sui suoi abitanti. L’eccesso, la confusione, ma anche una consuetudine con le avversità della fortuna tanto radicata da sfiorare il fatalismo; e poi l’improvvisazione, la cialtroneria, la disposizione spontanea e sanguigna di questa gente dalle tante anime (si parla in russo – nella versione originale, ovviamente – ma ci si saluta con un “al-salam-aleikum”…) si traducono in bozzetti e sequenze assolutamente esilaranti: le irruzioni di padre e figlio Bekhmuradov nei teatri, ad esempio, dove gli Otelli e gli Edipi più compunti rivolgono irripetibili insulti agli spettatori in platea; oppure il “sistema d’allarme”, a base di fili e campanelli, escogitato per controllare Alek durante il sonno; o ancora l’agguato al povero Safar ricoverato in ospedale, dovuto a uno scambio di persona del quale i responsabili si scusano cerimoniosamente. L’assurdo convive con l’assurdo: piovono sì tori dal cielo (Khudojnazarov assicura che un fatto simile è accaduto davvero, sulle rive del Mar Caspio!), ma le sparatorie sono all’ordine del giorno e i carri armati girano per strade e vicoli come se fosse la cosa più naturale del mondo (e qui l’allusione al clima di destabilizzazione politica di quell’area geografica e di quelle adiacenti è aperta e palese).
Luna Papa è un film collocato in qualche modo “fuori dal tempo”: fra elementi appartenenti alla contemporaneità e altri ormai desueti, di sapore arcaico, non vi è alcuna soluzione di continuità. Ma senza epoca sono anche i desideri e le paure di Mamlakat nei confronti della maternità, e la scena della seduzione – complice la luna? – si risolve in un’invenzione di leggera e arcana poesia (lo scivolamento e il metaforico “volo” della ragazza). Un motivo che si ripete anche nel finale, che vede librarsi in cielo – con la sola propulsione di un paio di malfermi ventilatori! – un tetto/tappeto volante occupato dalla prossima mamma e dalla sua intraprendente e loquace creatura: Abibullah, l’insolito narratore la cui voce fuori campo ci ha accompagnato fin dalle primissime inquadrature attraverso le peripezie della propria… futura nascita e che ci congeda mentre lascia per sempre un mondo spietato per un altro (glielo auguriamo!) più buono e giusto, finalmente lontano dallo “sguardo buio dei cuori di pietra”.
recensione di Marco Borroni
|