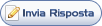Il 2 (15) luglio 1904
I primi tempi della primavera del 1904, alla fine di aprile, Anton Pavlovič arrivò a Mosca da Jalta, si ammalò e dovette mettersi a letto, cosa che accadeva di rado. Sopportava sempre con coraggio le sue indisposizioni, non si lasciava abbattere, non indossava mai la veste da camera, lottava contro la malattia. A Mosca rimase a letto tre settimane, lamentando forti dolori e continui a tutti i muscoli, alle gambe soprattutto, e soffrendo molto anche a causa di disturbi gastrici. Il dottor Taube, che lo aveva in cura, ci consigliò di recarci nello Schwarzwald. A Badenweiler, una località di cura per malati di tisi, dove Anton Pavlovič avrebbe potuto alloggiare in albergo o in un appartamento privato: di sanatorio egli non voleva sentir parlare, gli pareva che volesse dire la fine della vita.
Ai primi di giugno partimmo alla volta di Berlino, dove ci fermammo alcuni giorni per consultare il famoso professor E., il quale non seppe trovare nulla di meglio, dopo aver percosso ed auscultato Anton Pavlovič, che alzarsi, stringersi nelle spalle, salutare, e andarsene. Non potrò mai dimenticare il sorriso dolce, indulgente, imbarazzato quasi e confuso di Anton Pavlovič. Questo dovette procurargli un’impressione penosa.
A Berlino egli incontrò per la prima volta G. Iollos, ormai morto anche lui; trascorreva molto tempo a conversare insieme con lui e conservò poi nei suoi confronti una calda simpatia. Questa conoscenza mitigò in parte la dolorosa impressione ricevuta dalla visita del celebre specialista tedesco.
A Baudenweiler, i primi tempi Anton Pavlovič parve rimettersi in salute: camminava un pochino vicino alla casa, perché lo tormentavano l’affanno e l’enfisema polmonare; ogni giorno io e lui ce ne andavamo in giro in carrozza ed egli amava molto queste passeggiate lungo la strada bellissima fiancheggiata da ciliegi meravigliosi, in mezzo ai campi ben curati, ai prati in cui sussurravano i ruscelli dell’irrigazione artificiale, davanti alle piccole casette confortevoli con i minuscoli giardini dove, in un palmo di terreno, era coltivato amorevolmente l’orto e insieme gigli, rose, garofani. Questo paesaggio sereno riempiva di gioia Anton Pavlovič, gli piacevano questo attaccamento ed amore per la terra, rivolgeva con malinconia il pensiero alla Russia e fantasticava del tempo in cui i contadini russi avrebbero coltivato il loro pezzetto di terra con quella stessa cura amorevole.
Il dottor Schwörer, al quale ci rivolgemmo, si rivelò un uomo ed un medico meraviglioso. Anch’egli, probabilmente, capì che lo stato di salute di Anton Pavlovič era tale da destare preoccupazione, ma a maggior ragione si rivolse a lui con dolcezza, tatto ed amore straordinari. Anche Anton Pavlovič, che di solito era infastidito dalle visite mediche al punto che persino il nostro medico di casa ed amico Al’tsuller doveva sempre escogitare qualche pretesto per mascherare il carattere professionale delle sue venute, Anton Pavlovič ripeto, accolse senza lagnarsi e con molta serenità Schwörer, il quale dal canto suo seppe avvicinarlo con semplicità, come un buon conoscente.
In tre settimane di soggiorno cambiammo alloggio due volte. L’albergo “
Römerbad” era molto affollato, lussuoso, e noi ci trasferimmo in una villa privata, al pianterreno perché Anton Pavlovič potesse uscire da solo e starsene sdraiato al sole la mattina, maniera in cui era solito aspettare con impazienza che il postino gli portasse le lettere e i giornali. La guerra con il Giappone lo preoccupava ed egli ne seguiva puntualmente l’andamento. Presto anche questo soggiorno si rivelò inadeguato: Anton Pavlovič soffriva sempre il freddo, nella camera entrava poco sole e di là dal muro, la notte, si sentiva la tosse e si avvertiva la presenza di un malato grave. Ci trasferimmo all’hotel “
Sommer”, in una camera piena di sole. Anton Pavlovič cominciò a sentire meno freddo, a sentirsi meglio ed ogni giorno scendeva a prendere i pasti nella sala comune, al nostro piccolo tavolo separato. Trascorreva molto tempo sdraiato in giardino o seduto al balcone della sua camera ed osservava con grande interesse la vita della piccola Badenweiler.
L’instancabile vita della posta lo interessava in modo particolare ed in generale aveva, nei confronti della posta e dei postini, un amore tutto speciale.
Tre giorni prima di morire espresse all’improvviso il desiderio di possedere un vestito di flanella bianca (e mi rimproverava scherzando: vesti male tuo marito!). E siccome io gli dicevo che il vestito non si poteva comperarlo là, egli, come un bambino, mi pregò di fare una scappata alla vicina città di Friburgo e ordinargli un buon vestito in base alle misure. Questo viaggio mi prese l’intera giornata, Anton Pavlovič rimase completamente solo ma, come sempre, scese a pranzo a cena. Proprio mentre io stavo ritornando egli usciva dalla sala da pranzo e si vedeva tutto il suo orgoglio per la propria indipendenza; fu molto soddisfatto quando seppe che il vestito sarebbe stato pronto di lì a tre giorni.
Cominciò a far molto caldo. Il mattino appresso, mentre camminava per il corridoio, Anton Pavlovič venne colto da grande affanno e, una volta in camera, si allarmò, chiese di potersi trasferire in una camera con le finestre a nord e, due ore dopo circa, già ci sistemavamo in una camera al piano superiore, che aveva una bellissima vista sui monti e sui boschi. Si mise a letto; mi chiese di scrivere a Berlino, alla banca, che ci mandasse tutto il denaro che era rimasto. E quando io sedetti a scrivere, disse all’improvviso: “Di’ che mandino i soldi a tuo nome”. Mi parve strano. Mi misi a ridere e risposi che non amavo occuparmi di faccende di denaro (e questo lui lo sapeva) e preferivo che si facesse tutto come al solito. Così scrissi che li mandassero a
Herrn A. Tschechov (il denaro arrivò quando ormai egli giaceva senza vita). E mentre sistemavo le cose e mettevo in ordine la camera, domandò improvvisamente: “E allora? Ti ho fatto paura?” Può darsi che quel mio imbarazzo l’avesse indotto a pensare così. Tre giorni dopo queste sue parole avrebbero assunto un significato enorme, doloroso.
Per due giorni soffrì di forte affanno, tanto da dover stare a letto appoggiato a cinque cuscini, quasi seduto quindi; era diventato molto debole, non si alzava, respirava l’ossigeno, beveva soltanto caffè e tutto gli pareva senza sapore. La febbre non era alta e la tosse non lo tormentò quasi in questi giorni, i rantoli quasi non si sentivano.
La penultima notte fu spaventosa. Faceva molto caldo e scoppiava un temporale dopo l’altro. Si soffocava. La notte, Anton Pavlovič chiedeva di aprire la porta del balcone e la finestra, ma ora tenere aperto era orribile perché una nebbia densa, lattiginosa saliva fino al nostro piano e, come una schiera di spettri dalle forma più fantastiche, si insinuava e si versava nella camera e così per tutta la notte… Avevamo spento la luce elettrica, che dava fastidio agli occhi di Anton Pavlovič, ardeva un residuo di candela ed era tremendo il pensiero che la candela non dovesse bastare fino all’alba mentre continuavano a penetrare nuvole di nebbia, ed era particolarmente spaventoso quando la fiamma si metteva a guizzare, come sul punto di spegnersi… Perché Anton Pavlovič, riprendendo conoscenza non si accorgesse che non dormivo e che lo stavo vegliando, avevo preso un libro e facevo finta di leggere… Risvegliandosi mi domandò: “Che cosa leggi?” Il libro di Cechov era aperto sul racconto
Una storia strana e così gli dissi. Sorrise e disse debolmente: “Stupidina, chi porta con sé i libri del marito?” e cadde di nuovo nel torpore. Quando gli posi il ghiaccio sul cuore, mi allontanò con un gesto debole e borbottò confusamente: “Ad un cuore vuoto non serve…”
Quella notte era stata così spaventosa per il suo silenzio e le onde di nebbia che animavano di una strana vita ogni angolo, e il profilo di Anton Pavlovič, quasi seduto che respirava a fatica: tutto era così solennemente calmo e per ciò stesso orribile, che aspettai con impazienza, la mattina, il dottor Schwörer, per consigliarmi con lui e per far venire dalla Russia la sorella o un fratello di Anton Pavlovič. Mi pareva che avrei potuto perdermi d’animo se una notte simile si fosse ripetuta. E per quanto possa sembrare strano, alla morte, alla fine, non pensavo affatto… Il dottore mi tranquillizzò, affettuosamente, parlò con dolcezza ad Anton Pavlovič… La mattina le cose andarono un po’ meglio. Anton Pavlovič mangiò perfino un po’ di semolino liquido e chiese di essere spostato in una poltrona, più vicino alla finestra. E a lungo, interrompendosi di tanto in tanto, fece i suoi solitari “ai tredici”.
Verso sera andai alla farmacia per l’ossigeno e lui stesso mi disse di fare un bagno in piscina, una corsa nel parco, di prendere un po’ d’aria, perché in quei giorni non ero uscita dalla camera nemmeno per un minuto. Quando ritornai, vidi il suo viso che mi sorrideva con dolcezza e mi sentii un po’ più tranquilla, mi sembrava che il peggio fosse passato con quella orribile notte. A questo punto (mentre noi chiacchieravamo s’era sentito il suono del gong che richiamava tutti alla cena), mentre la cameriera mi portava qualcosa da mangiare, Anton Pavlovič si mise ad inventare un racconto: in una lussuosa località di cura, la sera si radunano tutti, stanchi per aver dedicato l’intera giornata ad ogni genere di sport; inglesi, americani ricchi, ben pasciuti, sono nell’avida attesa di una ricca cena quando — terrore! — si scopre che il cuoco se l’è squagliata, e questa tragedia ha conseguenze differenti sullo stomaco di tutta questa gente ricca, capricciosa. Parlava in modo così affascinante che mi misi a ridere di cuore e mi pareva che un peso mi si fosse sollevato dal petto. Prese le medicine, mi disse di togliergli i cuscini in più e si adagiò come al solito, dicendo con un sorriso: “Vedi? Oggi sto già meglio, non ho tanto affanno”. Presto si assopì e dormì quieto per tre ore circa…
Verso l’una si svegliò. Si lamentava di non poter star sdraiato, di avere nausea, di “non trovare pace” e per la prima volta nella sua vita chiese egli stesso di mandare a chiamare il dottore… Mi prese il panico, ma la sensazione di dover agire con risolutezza e rapidità straordinarie mi obbligava a tendere tutte le mie forze. Svegliai un nostro conoscente, lo studente russo L.L. Rabenek che alloggiava in quello stesso albergo e lo pregai di correre a chiamare il dottore. Svegliai il portiere e gli dissi di darmi del ghiaccio. Quando Rabenek ritornò ci mettemmo a spaccare il ghiaccio sul pavimento, in silenzio e rapidamente, aspettando l’arrivo del dottore. L’espressione di Anton Pavlovič era intensa, tesa, come se fosse in ascolto di qualcosa …
Il dottor Schwörer arrivò e con dolce amorevolezza cominciò a dire qualcosa, abbracciando Schwörer. Egli si sollevò con insolita sicurezza, si mise a sedere e disse, forte e chiaro: “
Ich sterbe”. Il dottore lo calmò, prese una siringa e gli fece un’iniezione di canfora, ordinò di dargli dello champagne. Anton Pavlovič prese il calice colmo, gettò uno sguardo tutt’intorno, mi sorrise e disse: “Da tempo non bevevo champagne”. Bevve fino in fondo, si sdraiò piano sul fianco sinistro, io feci appena in tempo ad accorrere, chinarmi su di lui attraverso il mio letto, chiamarlo: già non respirava più, si era addormentato piano, come un bambino …
E quando se ne fu andato quello che era stato Anton Pavlovič, una farfalla notturna, grigia, di dimensioni enormi entrò dalla finestra e prese a battere in modo penoso contro i muri, il soffitto, la lampada, come in un’agonia di morte.
Il dottore se ne andò, Rabenek si mise a scrivere i telegrammi per la Russia e presto se ne andò anche lui. Cominciò ad albeggiare, la luce elettrica si spense … Si sentì il cinguettio dapprima timido degli uccelli che si risvegliavano e poco dopo risuonò sempre più forte, gioioso; il suono di un organo, solitario e profondo, si versò nell’aria rinnovata. Pareva una fiaba: chi mai poteva suonare in chiesa così presto … Tutto l’insieme sembrava una prima messa funebre. Nessun accenno alla quotidianità delle cose violava quegli ultimi momenti. Silenzio solenne, né discorsi superflui, né parole superflue: soltanto la quiete e la solennità della morte.
Alle 7 del mattino arrivò il nostro ministro residente alla corte di Baden, Vl. Ejchler, rimase inginocchiato in silenzio, s’inchinò … Mi diede la parola che le formalità consuete sarebbero state revocate, non sarebbe venuta la polizia e la pace non sarebbe stata turbata. Grazie al dottor Schwörer il corpo venne lasciato lì fino alla notte seguente e nessuno, nessuno seppe che cosa era accaduto in quella notte tra l’1 e il 2 luglio …
Mentre uscivo dall’albergo, verso sera, mi venne incontro G. Iollos arrivato allora dalla Svizzera, da dove era partito non appena letti i giornali e, grazie ai buoni uffici suoi e di Ejchler tutto si svolse quietamente, in modo piano, nessuno mi importunò con carte e documenti. Arrivarono anche i soldi da Berlino, al nome di Anton Pavlovič, ma me li diedero subito, gentilmente, sebbene per legge io non avessi diritto di riceverli, ed anche il vestito era pronto … La notte seguente il corpo di Anton Pavlovič venne trasportato nella cappella. La mattina, io e la moglie del dottor Schwörer (nata Živago) trasformammo la cappella da cattolica in ortodossa, sistemammo il leggìo, le nostre icone. Arrivò il prete da Karlsruhe e celebrò la prima messa funebre. Facemmo grandi pressioni perché le autorità ferroviarie permettessero di trasportare la salma con il treno espresso. Io non volevo viaggiare a parte. Alla fine diedero il permesso di aggiungere al treno una carrozza con la salma.
Arrivò la prima moglie di mio fratello Vladimir Leonardovič, nata Bartel’s, ora
Ellen Tells, che mi fu di grande aiuto durante tutto quel triste viaggio. In Germania, su un binario morto dove si trovava la salma, ebbe luogo il secondo rito funebre; lo celebrò padre Mal’cev, una persona di animo meraviglioso, molto intelligente, dotata di humour. Le autorità tedesche chiesero che non si sentissero né il canto né la funzione religiosa. Arrivarono degli operai russi, portarono ghirlande verdi, di quercia, di fiori, addobbarono e abbellirono tutta la carrozza e, nel segreto e nella commozione risuonò il rito funebre e il canto delle voci soffocate … Padre Mel’cev pronunciò un discorso bellissimo, intenso, pieno di significato, di calore … A Berlino fummo costretti a fermarci. Nessuno era in grado di dirci quando e con quale treno saremmo potuti proseguire mentre cominciavano già ad arrivare ogni giorno le richieste da Mosca e da Pietroburgo. La nostra ambasciata si comportò in modo un po’ strano: come se ci tenesse a bella posta nell’incertezza, probabilmente perché le accoglienze in Russia non diventassero occasione di disordini: avevano paura di tutto. In uno dei tre distretti della Germania per i quali dovevamo passare non venne consentito alla carrozza con la salma di transitare insieme con l’espresso e soltanto un quarto d’ora prima della partenza del treno serale, grazie alle straordinarie pressioni del figlio di Iollos, riuscimmo ad ottenere il permesso.